
Un terzo della storia della Lazio ha avuto come teatro il Centro sportivo di Tor di Quinto. E di quei 37 anni, dieci li ho vissuti anch’io, quasi quotidianamente, la recinzione che giustamente si chiamava allora Campo Tor di Quinto (il titolo di “Centro Sportivo” lo avrebbe acquisito soltanto nel 1977). Giovane cronista appena assunto dal Corriere dello Sport, quando Antonio Ghirelli mi assegnò al notiziario della Lazio mi sembrò di volare. E volai smarmittando con la mia Cinquecento.
Era il 1965. Non pensavo – nessuno poteva pensare – che quel luogo un po’ desolato a Nord di Roma, ai margini di un quartiere tristemente noto per l’amore a pagamento, avrebbe condotto me nel cuore di una favola e spalancato alla Lazio le porte della gloria. Il Campo Tor di Quinto non aveva nulla di paragonabile al quartier generale delle squadre d’alta quota. Costruito in previsione delle Olimpiadi del ’60, in realtà la Lazio vi si allenava già due anni prima, da quando, cioè, un incendio aveva distrutto il vecchio impianto della Rondinella. Offriva l’essenziale: un solo campo di calcio, spogliatoi, magazzino, lavanderia, un piccolo appartamento, un ufficio. A me, però, quando per la prima volta varcai il cancello in ferro battuto che si apriva e si chiudeva a spinta, sembrò una reggia.

La società era stata appena salvata dal fallimento grazie ad un imprenditore-tifoso, Gian Chiaron Casoni, il quale, nominato commissario, convinse i giocatori ad accettare la spalmatura degli arretrati, consegnando pochi mesi dopo la patata bollente a Umberto Lenzini, palazzinaro venuto dal Texas.
Alla guida di una squadra che vivacchiava nella media-bassa classifica della serie A, c’era un toscanaccio in carne di 43 anni, Umberto Mannocci: livornese, bestemmiatore ma simpatico, senza peli sulla lingua. Rimase in sella per tre campionati. I giocatori gli volevano bene. Al mio arrivo non trovai grandi campioni, ma alcuni elementi di valore come i difensori Gasperi e Pagni, i centrocampisti Governato e Carosi, gli attaccanti Rozzoni e D’Amato. E il turco Can Bartù. Mannocci e Bartù andavano d’amore e d’accordo, perché i simili si fiutano e si accoppiano: entrambi con il gusto di “cazzeggiare”, spiritosi, dissacratori, senza angosce. Mi fiutarono e mi accolsero, rendendo più facile il mio debutto.
Questo fu l’inizio del Campo Tor di Quinto, futuro “Centro Sportivo Maestrelli”, della mia avventura nel giornalismo, di una società e una squadra che dondolando fra Serie A e B avrebbe messo in mostra una serie di personaggi da commedia.
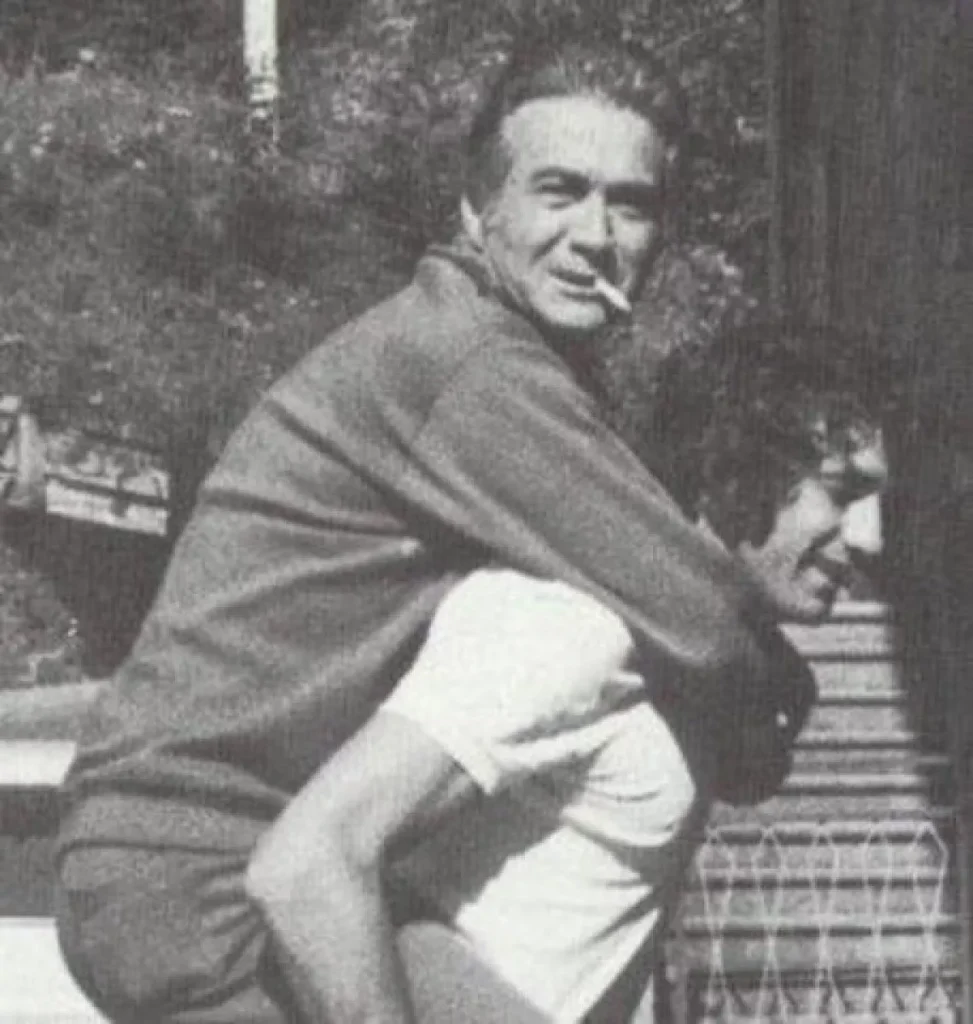
Il Tor di Quinto non è mai stato un college rigoroso, ma una scuola un po’ alla buona, di quelle dove anche i maestri si consentono qualche smarronata, gli scolari tirano i cartoccetti con le cerbottane e i bidelli gli tengono bordone. Il prototipo di allenatore folle e geniale è stato Juan Carlos Lorenzo, approdato a più riprese al comando della truppa biancoazzurra. Argentino impomatato come un tanghero, superstizioso più di cento napoletani, estroso stratega del pallone. Per dire: a 32 anni, mezz’ala nel Nancy, già partecipava (e primeggiava) al corso allenatori di Walter Winterbottom.
A Tor di Quinto s’inventò Alberto Mari, piccola ala destra, in marcatura su Suarez per battere l’Inter di Herrera, costrinse il terzino Filisetti a correre dietro una gallina per acquistare velocità e Chinaglia a ore di battimuro col pallone per ammorbidire il tocco. “Long John” è stata la sua grande scommessa: lo volle a tutti i costi, arrivò grasso come un’oca e sgraziato, lo mise a dieta, lasciava il campo di Tor di Quinto al tramonto e quando tutti pensavano ad un acquisto bidone, Lorenzo pronosticava: “Diventerà uno dei centravanti più forti d’Europa”.
Stringemmo una vera amicizia, cenavamo spesso insieme, facevamo il mercato da casa sua. Mi spiace che sia rimasto celebre soprattutto per le maglie bruciate dopo una sconfitta, l’ossessione del numero 8 (la stanza in albergo, i due anelli del pullman, l’orario, il calendario) e delle spie (ne vedeva ovunque). Provai una stretta al cuore quando Nanni Gilardoni, dirigente storico e il più grande tifoso laziale, lo cacciò da Tor di Quinto avendo saputo dell’alto tradimento: sì, senza informare nessuno, don Juan aveva firmato per la Roma. Il tanghero si era lasciato abbindolare, la storia sulla sponda giallorossa finì presto e male. Purtroppo non fu, allora, abbastanza sospettoso. Chiese scusa, tornò alla Lazio quattro anni dopo per riportarla subito in A.
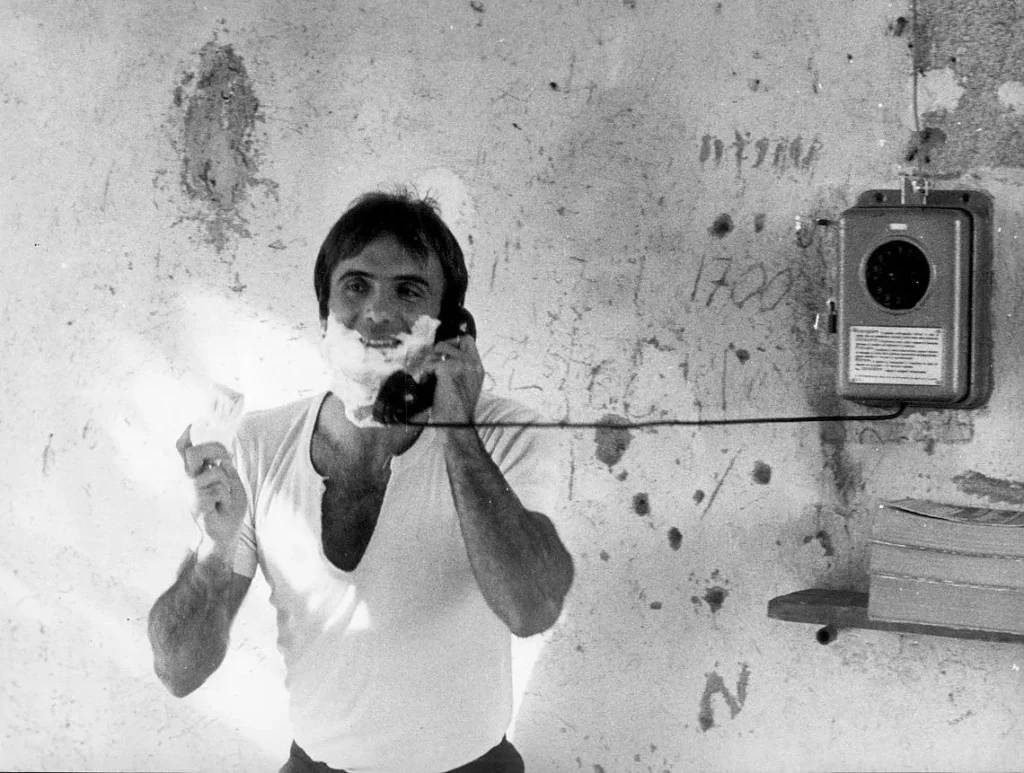
Parlavo dei bidelli. Certo, i bidelli di Tor di Quinto erano i massaggiatori, i magazzinieri, la lavandaia. Tra i primi il mio amicone divenne subito Armando Esposito, detto “pisello” per la piccola statura. Romano di borgata, ex cagnaccio bomber dei campionati dilettanti, ex dipendente dell’Enel. Aveva una parola di conforto per tutti, massaggiatore di anime oltre che di muscoli. Se un giocatore doveva rimanere fuori s’inventava un infortunio: “Nun poi gioca’, te faresti male”. Se due giocatori litigavano li faceva incontrare a sorpresa. Ci fu un momento in cui fra Gigi Martini e Luciano Re Cecconi – sì, proprio i due inseparabili gemellini della banda Maestrelli – cadde il gelo. Armandino li invitò, all’insaputa l’uno dell’altro, ad una battuta di caccia: i due si abbracciarono e partirono canna in spalla.
Poi c’era “Pelè”. Ribattezzato “Pelè”, perchè in realtà si chiamava Trasatti Giovanni, ma era basso, rotondo e goffo, immagine di contrasto con il campionissimo brasiliano. Custode di maglie, palloni e segreti. Di poche parole e grande discrezione. Viveva in una casetta accanto agli spogliatoi con moglie e due bambini. Da quanto tempo non si è mai saputo, da come si muoveva sembrava da sempre, come Mowgli o Tarzan (meglio Baloo).
La “sora” Gina lavava, stirava, cuciva. Allora non c’era lo sperpero di maglie come oggi, le divise erano tre e sempre quelle per una stagione, per gli allenamenti forse un paio. E sul bucato steso alle spalle degli spogliatoi erano ben visibili i rammendi di Gina. Della piccola comunità di Tor di Quinto faceva parte, infine, il giardiniere Francesco, un mago del campo da gioco, a tenuta di ogni intemperia. Tanto abile nel conservare il manto verde quanto inesperto nel maneggiare le armi. Trovò una pistola che Sergio Petrelli dimenticò nello spogliatoio. Chiamò Pelè: “Facciamo una gara di tiro? Comincio io”. Ma al primo tiro si spappolò un dito.

Di armi ne ho viste tante girare a Tor di Quinto, che negli anni 70 conobbe la sua apoteosi con l’avvento della squadra più pazza del mondo. Un luna park per noi giornalisti – ma non solo – che avevamo accesso libero agli spogliatoi (oggi, che per intervistare un giocatore devi avere l’ok di società, uffici stampa, procuratori, sponsor e quant’altri, pare fantagiornalismo) e persino al campo: ricordo una sfida all’ultimo rigore con Bob Lovati – vinta, ebbene sì – e la partecipazione ad una partitella che un’entrata di Polentes ridusse a pochi minuti. Il pubblico – ingresso sempre consentito – andava in delirio per il confronto senza esclusione di colpi di metà settimana fra la squadra di Chinaglia e quella di Martini.
Ho visto di tutto a Tor di Quinto nell’era Maestrelli. Ho visto Martini e Re Cecconi scendere sul campo col paracadute. Ho visto Chinaglia abbattere un muro del magazzino con il fucile “uguale a quello con cui hanno sparato a Kennedy”. Ho visto l’autista Alfredo Recchia cercare disperatamente il pullman che Wilson gli nascondeva. Ho visto i gemelli Maurizio e Massimo Maestrelli rotolare sul tappeto verde del giardiniere Francesco come se giocassero nel giardino di casa. Ho visto nascere il più singolare degli scudetti in un’isola felice chiamata Tor di Quinto. L’isola (dal 1977 “Centro sportivo Tommaso Maestrelli”), dove Eugenio Fascetti avrebbe poi creato, nella memorabile stagione 1986-‘87, il miracolo della “Lazio -9” e dove sarebbe cominciato a germogliare anche il secondo titolo, poiché a piantare il seme del tricolore di Eriksson fu, nel 1990, Dino Zoff, accolto da 6.000 tifosi al suo primo allenamento.
Cinque anni dopo, il vecchio centro di Tor di Quinto ha chiuso per sempre la propria gloriosa esistenza. Al suo posto è sorta la caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto”. Del luna-park Tor di Quinto sono rimasti il campo da gioco e il busto bronzeo di Maestrelli. Ma per la Lazio e per chi accanto alla Lazio ha vissuto quegli anni, rimane un irripetibile pezzo di storia.
Franco Recanatesi
Fonte la Repubblica
