
La vita lo ha preso di mira da subito, gli ha tatuato addosso un reticolo di ferite. Eppure da ogni prova è riemerso come da un’insopportabile apnea, respiro feroce, polmoni spalancati. Molti si sarebbero piegati e spezzati, invece Arcadio Spinozzi è come Di Caprio in quel film, è il Revenant di Tortoreto Lido, ciò che non ti uccide ti rende più forte. Non rimpiange nulla dei suoi 68 anni, anche se qualche calice che sapeva di cicuta avrebbe preferito non berlo. Come da bambino, vive a Tortoreto, un posto che ancora negli anni ‘50 era “una lingua di sabbia con sopra un villaggio, pescatori marinai e contadini, la povertà assoluta, spesso nulla da mangiare, una vita di sacrifici estremi ma ci si aiutava tutti”.


Lui ne è uscito facendo il calciatore, stopper o libero o terzino destro a seconda degli allenatori, 101 partite di serie A e 135 in B ma potevano essere molte di più, alla Lazio sei anni memorabili e distruttivi, dal 1980 al 1986. I laziali lo amano da quel dì e mica smettono: “Qualche anno fa sono arrivate più di sessanta persone a sorpresa, da Roma, in pullman o in moto, erano nonni ma pure ragazzi, io non conoscevo quasi nessuno eppure hanno voluto passare la giornata con me ed è stata una meraviglia: settembre, pochi turisti, un sole che innamorava, e queste persone che mi volevano così bene”. È un drago insonne, non dorme da secoli, le notti tutte a occhi aperti. Ce lo racconta bene Andrea Sorrentino sul “Corriere della Sera”, edizione di Roma.


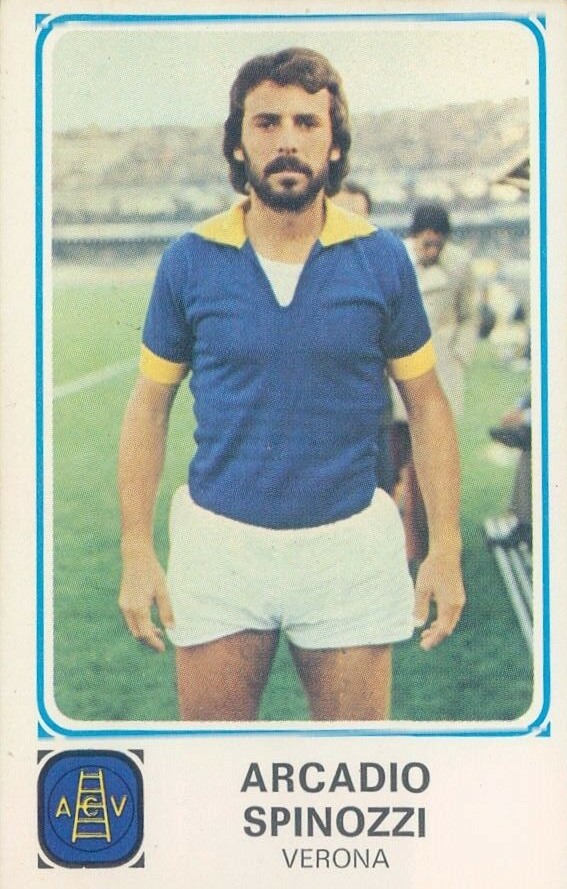

Ha scritto due libri, di cui uno, Le facce del pallone, censurato a lungo dagli editori, perché denunciava il marcio della serie A e le complicità con istituzioni e giornalisti assai prima di Calciopoli. Il calcio gli ha dato tutto con una mano e tutto gli ha tolto con l’altra, elencare per credere. A 20 anni, giovane difensore della Sambenedettese, combatte una malattia misteriosa, astenia e febbri quotidiane originate da un forte stress psicofisico e durate oltre due anni, fino a lambire gli ospedali psichiatrici; a 25 sopravvive per caso e per ventura al disastro ferroviario di Murazze di Vado dell’aprile 1978, scavando a mani nude tra le macerie di un vagone ristorante sdraiato in bilico su un burrone; a 30 viene implicato da mani ignote e perfide nel caso di Emanuela Orlandi, ma era tutta una farsa ignobile; a 45 diventa finalmente allenatore ma non lavorerà mai, visto che da una vita combatte i liquami del sistema calcistico e sarà parte civile, invano, nei processi alla Gea e a Calciopoli.
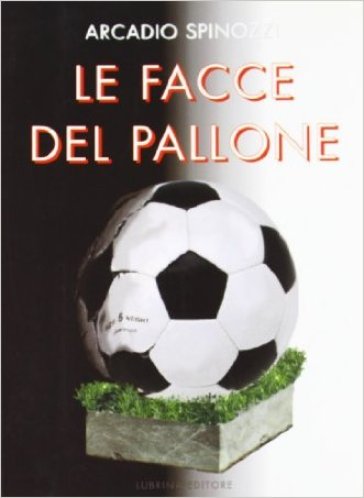
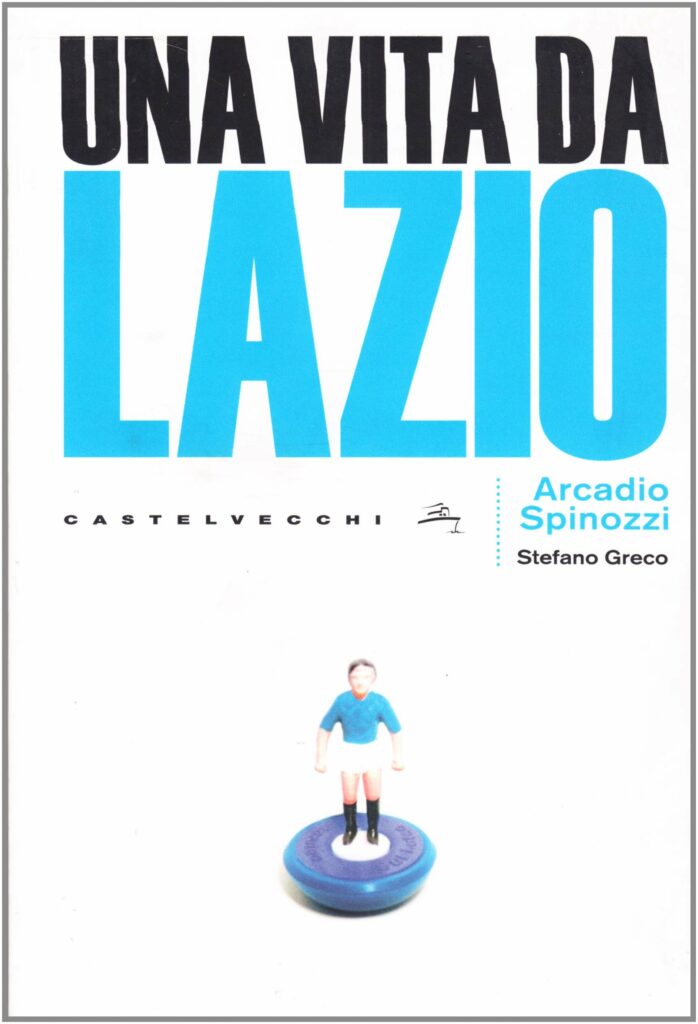
Eppure il peggio doveva ancora arrivare, dice: “In fondo gli ultimi anni sono stati i più difficili. Per fortuna la mente ha una capacità incredibile di modellarsi a seconda delle situazioni, anche le più dure”. Perché per Arcadio ci sono state anche malattie, guarigioni e ricadute, la perdita di qualche persona cara e ultimamente quelle di “amici e colleghi, anche per colpa del Covid qui ha colpito duro”. Gli sembra che pure la memoria ormai vacilli: “Comincio a non ricordare bene alcune cose eh, mi sto seriamente preoccupando”.

Macché. Snocciola sicuro fatti, misfatti, aneddoti, partite, liti e resurrezioni sparse di una vita in salita, immersa nel calcio ma spruzzando sdegno per come era pilotato e inquinato. Poteri e superpoteri, dice lui, hanno ridotto le sue urla a un pigolio, mentre chi l’ha voluto ascoltare e auscultare, i tifosi della Lazio per esempio, lo considera un pezzo di cuore: “Sei anni micidiali, che non giovarono ai miei nervi già delicati. Sono arrivato alla Lazio tre giorni prima della retrocessione in B per il calcioscommesse, sono andato via poco prima del -9 per il caso-Vinazzani, e in mezzo accadde di tutto. Eppure la gente mi vuole sempre bene. Non ero un ruffiano come altri calciatori, ero uno vero”. Ogni capitolo della vita di Arcadio meriterebbe un romanzo o un racconto a parte, si deve per forza sintetizzare.

La malattia. “Stavo per esordire finalmente in serie B con la Samb, ma di colpo smetto di giocare, poi di muovermi, non mi alzo più dal letto, zero energie, peso 40 chili, penso di morire. I medici mi danno solo antibiotici, poi iniziano con gli psicofarmaci, così per due volte rischio la pelle per un’intossicazione. Mi mandano negli ospedali psichiatrici dove finalmente un dottore illuminato mi fa parlare e capisce che avevo vissuto un forte stress causato dalla vita che facevo, in piedi dalle 6 di mattina alle 10 di sera tra scuola, allenamenti, partite, ore di trasferimenti al giorno, per anni, da adolescente: ‘Tu in realtà non hai niente’, mi dice. Sul lungomare incontro il mio vecchio allenatore alla Samb, mi giro perché mi vergogno a farmi vedere in quello stato dato che ero una larva, lui mi riconosce lo stesso, mi incalza, mi chiede di tornare a trovare i miei compagni, piano piano torno alla vita e al calcio. Ma quei due anni e mezzo di calvario mi hanno lasciato segni nella mente e anche nel fisico, perché dopo non sono stato mai più al massimo coi muscoli. Per non parlare dell’insonnia perenne”.



Il disastro ferroviario. “Con il Verona prendiamo il treno per Roma, siamo nei vagoni di testa. Ci chiamano per il pranzo nel vagone ristorante, la cosa ci salva la vita: dieci minuti dopo il nostro treno investe il Bari-Milano che portava 20 ore di ritardo ed era deragliato sui binari per la frana di una collinetta, il vagone in cui eravamo noi poco prima finisce nel burrone, ci saranno quasi 50 morti. Il vagone ristorante invece rimane in bilico sulla scarpata, invaso da fango e detriti e coi finestrini bloccati, io strisciando sui gomiti raggiungo l’uscita, poi anche i miei compagni, ricordo Bachlechner, Maddè, ricordo Ferruccio Valcareggi che si ruppe tre costole, il freddo e il buio, la pioggia, la certezza che stessi per morire, i moribondi e i morti intorno, poi la salvezza, i tifosi dell’Hellas che ci prestano il loro pullman per tornare a Verona, e dopo soli tre giorni ci impongono di giocare lo stesso la partita: la perdemmo, come quasi tutte le altre dopo l’incidente”.

Il caso-Orlandi. “La notizia, ovviamente infondata, del mio coinvolgimento nel rapimento è contenuta in una lettera anonima che arriva all’Ansa di Milano, spedita da Bari. In quei giorni a Bari giocava la Nazionale, c’erano tutti i dirigenti del calcio, compresi quelli con cui io litigavo già da anni, mica solo Moggi alla Lazio. Insomma il mandante era uno di loro, io ero considerato da tutti un pericoloso rompiscatole. Ma l’effetto della notizia fu devastante, finii dentro il tritacarne: i miei poveri genitori seppero tutto dalla tv, quindi ebbero persino il dubbio che la cosa fosse vera, e comunque dalla vergogna non uscirono di casa per mesi. Intanto mi arrivavano minacce di morte per lettera o al telefono, negli stadi beccavo insulti orrendi da tifosi e avversari”.

La Lazio. “Dopo Samb, Verona e Bologna, arrivo a Roma nell’estate 1980 e subito la squadra retrocede in B. Ricordo René Van de Kerkhof, il nuovo acquisto olandese, che scappa dal ritiro di notte e non si farà più vedere. Partiamo benissimo in B, a dicembre +8 sulla quarta e nessuna sconfitta, nemmeno in amichevole. Ma i dirigenti erano Moggi, Sbardella, questi personaggi qua. Io guido le proteste della squadra per promesse non mantenute e stipendi non versati, così viene creato un clima incredibile contro di noi, la stampa imbeccata da chi di dovere ci dipinge come mercenari. Così gli allenamenti diventano un incubo, i tifosi ci insultano in ogni modo, a volte rimaniamo fino a notte assediati negli spogliatoi di Tor di Quinto, ho visto compagni piangere per la paura. Io venivo da un ambiente di grande povertà e onestà, quello di casa mia, e scopro questo mondo di squali e di polemiche costruite ad arte per screditare i giocatori, non pensavo che il calcio potesse essere così. Comunque la squadra si sbriciola e non va in A, col famoso rigore sbagliato da Chiodi contro il Lanerossi Vicenza, ma i danni erano stati fatti prima. Ripercussioni anche l’anno dopo, al punto che ci salviamo dalla C col 3-2 al Varese a fine campionato e le magie di D’Amico. Ma io ero già quello che doveva andare via, descritto come personaggio difficile che creava problemi al gruppo, solo perché pretendevo si mantenessero promesse, minacciavo comunicati stampa… ero uno taciturno ma quando vedevo ingiustizie o perfidie ai nostri danni perdevo la testa, potevo fare qualsiasi cosa. Ebbi uno scontro incredibile perché mi volevano vendere alla Cavese, ma io minacciai che avrei smesso di giocare. Poi rimango, e rimane pure l’etichetta del rompiscatole, pure nella gestione Chinaglia, che meriterebbe capitoli a parte. Vado via nel 1986 dopo due anni di A e la retrocessione, ma sempre a testa alta. Di me ci si poteva fidare, i tifosi mi vedono come un simbolo onesto di quegli anni così particolari per il club. Anche perché ho pagato per tutta la vita le mie guerre con certi dirigenti”.

Dopo il ritiro. “Ci metto dodici anni a prendere il patentino da tecnico di prima categoria, a pieni voti, mentre grazie al patentino di seconda vinco una Coppa Italia con la Primavera dell’Udinese, i ragazzi erano così felici. Ma del mio gruppo di diplomati sono l’unico a non lavorare mai, mai un colloquio, mai neppure una telefonata. Solo per pochi mesi faccio il vice di Boskov al Perugia, stop. C’era già la Gea, del resto. Tento di fuggire da questo mondo di soldi, tv e plastica, vado in Ghana, alleno per un mese poi torno. Ho perso tanto tempo. Poi inizio la mia battaglia contro il sistema che mi ha emarginato, da vent’anni sono immerso in cause e ricorsi, l’ultima è di qualche mese fa. Ho ricevuto minacce brutte e controlli di ogni genere, mi sono costituito parte civile al processo di Calciopoli e a quello della Gea, per cose che io denunciavo pubblicamente da anni: designazioni arbitrali pilotate, pasticci tra giocatori e allenatori della stessa scuderia, gli opinionisti tv manovrati anche loro, una sceneggiata che andava avanti da decenni.
Provo a coinvolgere amici ed ex compagni di squadra, a decine, nessuno mi segue, hanno paura, l’unico a darmi ascolto è Zeman, un altro che ha pagato con licenziamenti ed esoneri il suo essere contro, mentre a rovinargli i risultati ci pensavano gli arbitri. Al processo Gea il pm Palamara prima mi aveva inserito come parte civile, in quanto allenatore emarginato dal sistema. Poi nell’udienza successiva, senza che fosse cambiato nulla, Palamara se ne esce: ‘Su Spinozzi mi rimetto alla decisione del giudice’. Il giudice allora decretò che io non potevo più essere parte civile perché il processo non riguardava gli allenatori… ma come, era il processo alla cupola della Gea! Abbiamo protestato vivacemente, il giudice minacciò di chiamare i carabinieri. Altra cosa curiosa quando arrivò la memoria di Luciano Gaucci da Santo Domingo: rivelazioni scottanti di tutti i tipi, compreso il racconto di quando lui stesso diceva di aver portato valigie piene di soldi alla Gea. Cose che non mi sorprendevano: ai tempi del Perugia vedevo sempre giocatori che uscivano dalla sede del club con buste del supermercato gonfie di denaro. Ma alla fine il memoriale non viene inserito agli atti, l’avvocato Bongiorno fa notare che c’è un vizio di forma perché al memoriale manca non so quale firma ufficiale, e il giudice accoglie l’obiezione. Si può dire che il processo finirà a tarallucci e vino, del resto pure quello su Calciopoli non avrà conseguenze serie per gli imputati, anche se i pm di Napoli mi ridiedero fiducia nella magistratura, furono incorruttibili”.
Ci sarebbe da parlare ancora di trentamila intercettazioni di quegli scandali che giacciono ancora e verranno dimenticate, del calcioscommesse del 1980 che Arcadio visse e vide srotolarsi davanti ai suoi occhi, di Juan Carlos Lorenzo e le sue pozioni magiche alla Lazio, di troppe partite dai risultati strani all’epoca e adesso, di innumerevoli aneddoti, sofferenze, risalite. Grazie, Arcadio, alla prossima, scrive Sorrentino. “Grazie a te. Ma dimmi invece, tu come stai, come ti va la vita? Raccontami”.
