
Era il 2 luglio 1994 quando Andrés Escobar, difensore della Nazionale colombiana e simbolo di rettitudine e fair play, fu ucciso a colpi di pistola nel parcheggio di un bar di Medellín. Pochi giorni prima, il 22 giugno, la Colombia era stata eliminata dai Mondiali di Usa ’94 dopo una sconfitta contro gli Stati Uniti, resa ancora più amara da un suo sfortunato autogol. Il legame tra quei due eventi è stato oggetto di indagini, congetture e simbolismi, ma a trent’anni di distanza resta una verità ambigua, a metà strada tra pallone e piombo.
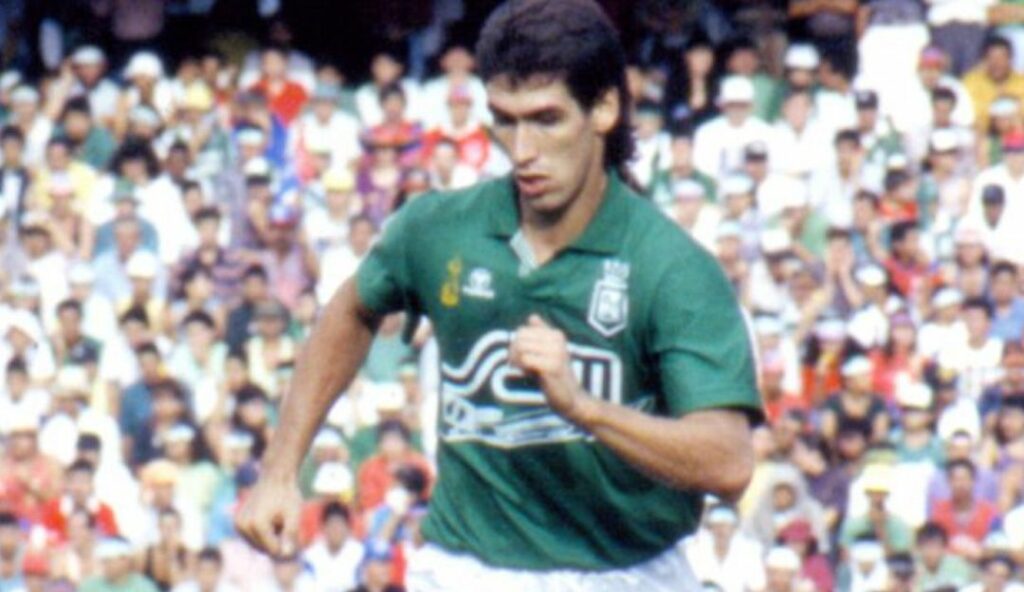
A inizio anni Novanta, la Colombia sembrava sul punto di diventare una potenza calcistica mondiale. Aveva battuto 5-0 l’Argentina a Buenos Aires durante le qualificazioni e si presentava ai Mondiali statunitensi come una delle possibili sorprese. Il regista Carlos Valderrama, il giovane talento Freddy Rincón, l’ala Faustino Asprilla: la squadra guidata da Francisco Maturana incarnava lo stile tecnico e il carattere del calcio sudamericano, ma anche le contraddizioni di un Paese spaccato dalla violenza del narcotraffico.

Dietro le quinte, infatti, agivano poteri oscuri. I cartelli della droga, in particolare quello di Medellín, avevano infiltrato il calcio colombiano: compravano giocatori, sponsorizzavano club, lavavano denaro negli stadi. Pablo Escobar, boss del cartello omonimo (nessuna parentela con Andrés), aveva fatto del calcio un territorio d’influenza. Anche dopo la sua morte nel 1993, l’ombra del narcotraffico non smise di incombere.
Durante la partita Colombia-Stati Uniti, valida per la seconda giornata del girone A, Andrés Escobar nel tentativo di intercettare un cross deviò il pallone nella propria rete. La Colombia perse 2-1, e fu eliminata al primo turno. Per una nazione che aveva investito sogni e denaro su quella squadra, fu un disastro. Escobar, però, non si nascose: scrisse un articolo sulla stampa colombiana in cui invitava tutti alla calma e alla riflessione, chiudendo con la frase: “Ci vediamo presto, perché la vita non finisce qui”. Sei giorni dopo, fu ucciso.

La notte del 1 luglio 1994, Andrés Escobar si trovava in un locale notturno di Medellín. Dopo una discussione con alcuni uomini che lo insultavano per l’autogol, uscì nel parcheggio. Lì, fu raggiunto da sei colpi di pistola. A sparare fu Humberto Muñoz Castro, guardaspalle dei fratelli Gallón Henao, imprenditori con legami con il narcotraffico e scommettitori incalliti. Muñoz fu condannato a 43 anni di carcere, poi ridotti a 26, ma ne scontò solo 11. I mandanti non furono mai ufficialmente perseguiti.
Secondo la versione processuale, si trattò di un delitto scaturito da un litigio personale, degenerato in omicidio. Ma in molti, dentro e fuori la Colombia, continuarono a leggere quella morte come una vendetta legata al calcio scommesse e alla perdita di denaro causata dall’eliminazione della Nazionale.
Andrés Escobar aveva 27 anni, una carriera brillante al Nacional di Medellín e l’intenzione di trasferirsi in Europa. Era considerato un “puro”, un esempio di correttezza e impegno, in un ambiente spesso corrotto e pericoloso. La sua morte scosse il Paese. Al funerale parteciparono oltre 120 mila persone. I suoi ex compagni lo ricordano come un uomo gentile, educato, che non alzava mai la voce. La sua uccisione segnò un punto di non ritorno nella storia del calcio colombiano: un trauma che impose la necessità di un cambiamento.

A distanza di anni, resta difficile dire se Andrés Escobar fu ucciso per il suo autogol o a causa di un contesto malato in cui quell’episodio fu solo il detonatore. Di certo fu una vittima innocente, un simbolo sacrificale di un calcio inquinato dai soldi e dalla violenza.
Il suo ricordo, però, sopravvive. Ogni anno, il 2 luglio, i tifosi del Nacional gli dedicano un minuto di silenzio. In Colombia, oggi, si parla ancora di lui come del “Caballero del fútbol”. Forse proprio perché, in mezzo al caos, cercò di essere l’unica cosa che il suo Paese aveva dimenticato: un uomo giusto.
Mario Bocchio
