
Un mondiale di calcio narrato come un romanzo epico, dove tutto è vero ma tutto è trasfigurato dalla scrittura, e dalla gran vocazione che aveva Giovanni Arpino nel raccontare storie. Sono passati quarantasei anni dalla rovinosa Coppa del mondo di Stoccarda ‘74, quando sarebbe bastato un pareggio nella terza partita contro i polacchi per non rientrare subito a casa, ma quel pareggio non venne. Azzurro tenebra, efficacissimo titolo che annuncia la tempesta sin dalla prima riga, anzi dall’epigrafe: «Il ricordo comincia con la cicatrice». È un modo per accostare atmosfere, ritratti in punta di penna, memorie con e senza ferite di un calcio malato e guarito tante volte. Ed è l’occasione per frequentare uno scrittore ingiustamente trascurato.
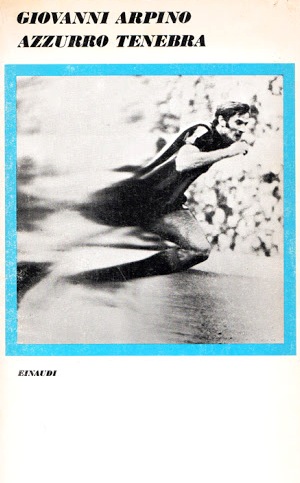
Libro randagio, di passaggi e paesaggi e personaggi. Lo Zio e il Vecio, cioè Valcareggi e Bearzot. E poi Giacinto (Facchetti), il Bomber (Gigi Riva), San Dino (Zoff), Giorgione (Chinaglia), il Golden (Rivera), Fabio il geometra (Capello), il Baffo (Sandro Mazzola). Acquistano tutti, pagina dopo pagina, lo spessore narrativo che si sovrappone al profilo umano e sportivo più noto, inventati e più veri del vero. Arpino, che nel romanzo è Arp, ne racconta alcuni tenendo la distanza e con altri, pochi, invece parla.
I dialoghi col Vecio, con Giacinto e con Bibì (il giornalista Bruno Bernardi, al primo mondiale della carriera nel ‘74 accanto ad Arp, per La Stampa), ma anche con Gauloise (l’allenatore Carletto Parola, l’uomo della rovesciata più famosa di tutti i tempi) sono il tessuto profondo del libro, lo strumento per raccontare l’avvicinarsi della tempesta, sotto quel cielo ferroso, metaforico ma anche fisico (c’è tanta pioggia) in cui l’azzurro vira verso la tenebra più oscura, passando dalle periferie sconsolanti della «verde Unnia» e da luoghi residuali, l’hotel del ritiro azzurro in mezzo alla campagna e al nulla, certi bar dove consumare liquori e parole fino a notte, le tribune degli stadi, compreso quel magico momento in cui si svuotano e l’inviato resta solo a picchiare sui tasti. Un libro di sport (uscì per Einaudi nel 1977, tre anni dopo il mondiale), di giornalismo, di luoghi. Un libro con tante figure svanite nel tempo, come il Grangiuán Brera o Gauloise, lo Zio Valcareggi e il Manager, Italo Allodi. Ma con altri che invece restano, persone in carne, ossa e parole, a mezza strada tra i gesti di ogni giorno e la fissità della pagina.
È il caso del giocatore più amato da Arpino, cioè Giacinto Facchetti. Il mai abbastanza compianto ex presidente dell’Inter è stato anche un personaggio da romanzo. «Per me il libro fu una sorpresa, Giovanni non me l’aveva detto. Ci eravamo conosciuti quando venne a intervistarmi per un programma Rai, ho ancora la cassetta, si vede che scendo le scale e lo incontro, tutto in bianco e nero ovviamente. Diventammo amici, mi incuriosiva uno scrittore vero, capace di inventare storie, mentre io avevo sempre fatto una fatica tremenda a mettere insieme qualche riga a scuola. E poi avevo ormai smesso di leggere, così Giovanni mi consigliava titoli, mi regalò La suora giovane che aveva scritto lui, mi fece conoscere Dino Buzzati e, poco alla volta, i classici italiani e stranieri. Se amo i libri, e se poi non ho più smesso di leggere, lo devo a lui».

Dentro Azzurro tenebra, che originariamente aveva proprio Facchetti in copertina, si vedono giocatori e giornalisti che riescono a comunicare e scambiarsi cose anche importanti. Colpisce, oggi, quando i due mondi sono più che distanti.
«Non è più possibile, ci sono le interviste programmate, i doveri verso gli sponsor e le televisioni, ma io penso sia sbagliato. Con Arpino parlavo nell’ora d’aria, al mondiale, e lui cercava sempre di capire le persone. Nel romanzo mi descrive molto meglio di come io fossi, al limite come voleva che io fossi: spero di non avere troppo deluso quella figura un po’ ideale. Noi eravamo una generazione in cui la famiglia aveva ancora un ruolo centrale. Giovanni fece da padrino a uno dei miei figli, e io allo stesso tempo ero sempre legatissimo a mio padre ferroviere; quando presi il premio della Coppa dei Campioni lo confrontai al suo stipendio quasi con vergogna. Quando lui andava a fare la spesa, chiedeva alle mie sorelle dove costasse meno la roba, e io non ho dimenticato». Il libro procede per frasi brevi e scattanti. «Non il partire, ma il tornare è un po’ morire». «Non fare lo snob. Solo le parole guariscono le parole». «È sempre sull’anima che bisogna giocare, si tratti del Papa, di Stalin o di un Bomber. Qualcuno chissà dove capirà».È come se l’inviato speciale si sentisse attratto dallo spettacolo umano del pallone eppure scettico, un osservatore di proprie e altrui solitudini. «Diventa difficile stringere in mano questo mondo: è liquido».

Ma se smetti ti ritrovi inviato speciale e devi seguire guerre o processi – scattò il Grangiuan: – Non pentirti mai di questo povero pallone, amico. Sai cosa capita ai cosiddetti grandi inviati? Sifilide, alcolismo, solitudine”
C’è una forte, continua solidarietà maschile di passionali raminghi e mai cresciuti, («Siamo solo dei bambinacci, sussurrò il Vecio»), sempre fuori dal coro dove invece si segnalano le Iene (cioè i giornalisti col pennino avvelenato, in cerca di scandali e polemiche) e le Belle Gioie (quelli che aspettano solo di assecondare, con voce melliflua). «Le tegole dei palazzi stavano diventando d’oro acceso. Rimasero in silenzio a guardare quel gracile trionfo». Si parte da uno stadio, «subito presi dall’incanto dell’erba vuota» e si arriva lontano, in luoghi dove quasi mai ci si sente a casa. «Perché il football è anche quello che non è». Il controcanto di Arp spetta in molte pagine a Bibì, cioè Bruno Bernardi. «Aveva un volto di bambino consunto, dove il rosa e il tenero andavano componendosi in rughe precoci».

Un volto non troppo cambiato, in fondo, anche ora che Bibì è in pensione. «Con Giovanni nacque un feeling naturale, io avevo 33 anni, lui era un maestro ma mai distante, si sporcava le scarpe e le mani, ascoltava, dava e prendeva. L’ho visto scrivere una colonna in otto minuti, cronometrati: sono più o meno settanta righe, e neppure una sbavatura. Abbiamo girato il mondo insieme per dieci anni, da Cruijff alla lattina in testa a Bordon, lui aveva vinto lo Strega e il Campiello, non poteva sprecarsi, per questo non dettava mai a braccio. Scriveva, di solito, commento e pagelle, e articolesse di colore. Era come se Arp osservasse la nostra tribù da uno sgabello. I dialoghi del libro sono al novantacinque per cento veri».
Ma senza mai esagerare con il tocco d’esterno. «Il talento si mette in mostra anche senza far niente». Tra le pagine c’è grande rispetto per il Grangiuán, per Brera da cui Arpino si sarebbe poi distaccato duramente, per ragioni mai del tutto chiarite. E nella squadra che già puzza di cadaverina, votata allo sfacelo («la Banda Crepacuore») c’è l’affetto per i campioni ruvidi e silenziosi, ad esempio San Dino. «Con Giovanni eravamo proprio amici» ricorda Zoff. «Mi invitava a mangiare da lui, veniva a cena da noi. Era una persona straordinaria che cercava sempre l’uomo. Azzurro tenebra rimane un libro affascinante, che rende benissimo l’atmosfera di quei giorni. Molto autentico, come tutto di lui».
“Ancora vide Giacinto. Si teneva aggrappato all’indio Yazalde in un intrico di ossa mulinanti. Ormai gli era impossibile sgiungersi, apparivano rappresi in un unico sudore. Bevevano lo stesso fiato d’aria fradicia, tempia contro tempia, sputavano saliva e fiele sullo stesso filo d’erba. Il groviglio dei gomiti era cespuglio spinoso. Nello scatto parallelo il ruotare delle ginocchia diventò sincrono, ciascun muscolo ciascuna carne parvero la concreta ombra dell’altro. Sulla palla alta che volò via, solo un astuto spigolo di Giacinto prevalse. Ricaddero nel vuoto come mostruosi gemelli e toccando terra si fecero più stretti d’odio”
«Li vide entrare, figurine smilze negli spazi immensi dell’erba». C’è questo modo di dilatare, di partire da un pallone per arrivare lontanissimo. «Infatti le pagine da antologia in Azzurro tenebra non sono quelle sportive» dice il critico letterario Giovanni Tesio. «Io sceglierei gli incontri tra Arp e il cane randagio e malandato, che rendono molto bene l’atmosfera di solitudine che permea il romanzo. Riletto dopo trent’anni, si coglie una musica profonda e profondamente malinconica. Un libro atipico che parla di sport, non solo di calcio, e delle molte derive all’orizzonte, intuite con occhio profetico, l’occhio di uno scettico partecipe. Arpino è sempre stato considerato un narratore di storie, un agonista generoso, uno che sapeva rischiare e spendersi e pagare. Fuori da qualunque corrente o ideologia, è stato tante cose insieme: romanziere, poeta, giornalista, epigrammista, drammaturgo, favolista. Un moralista nel senso alto, ampio del termine».
Procedendo verso la tenebra, il libro si spalanca ad altezze luminose: «Monaco non era lontana, contro il cielo diafano cominciavano ad alzarsi file di palazzi rettangolari, vespai di finestre e balconi aperti al sole. Un aliante tracciava curve lentissime, rovescian-dosi poi per offrire il candore del ventre». Arpino aveva la capacità di variare registro all’improvviso, anche nella fatica del vivere. «Un giorno lo incontrai a Torino davanti all’ospedale Molinette» ricorda Bernardi «ma non mi disse di essere stato lì a curarsi. Mi invitò a cena. Si presentò elegantissimo, con un foulard di seta per nascondere la gola malata. Alla fine mi disse: ‘Bruno, la metteremo in quel posto a tutti quelli che ci vogliono male’ e tirò fuori dalla tasca un gettone: ‘Ecco, tieni, così non hai più scuse per non chiamarmi‘. Ma io non riuscii più a telefonargli, Giovanni faticava a parlare e io soffrivo nel sentirlo così». Arpino se ne andò col suo stile, appartato come il cane randagio del libro. «Perché noi del football siamo tanti e siamo soli».
