
Lo avete capito ormai da tempo. Quasi sempre non amiano i “vincenti”, quelli baciati dalla sorte, sempre perfetti, belli e fortunati. Quelli che hanno talento e che lo sanno sfruttare appieno. Di loro sono piene le pagine dei giornali, il web e le chiacchiere dei salotti bene delle televisioni a pagamento.
Poi ci sono gli altri. Quelli che il talento l’avevano e lo hanno gettato alle ortiche. Quelli che il talento l’avevano ma hanno preferito fare altro. Quelli che il talento l’avevano ma la dea bendata ha voltato loro le spalle. In quest’ultima categoria, quella che amiamo di più, ce ne sono davvero di tutti i tipi. Quelli che hanno avuto tragici incidenti, in campo e fuori, che hanno cambiato il corso delle loro carriere.

Abbiamo raccontato di tanti di loro. Ma esiste – come scrive Remo Gandolfi – un altro modo in cui la dea bendata può voltarti le spalle, abbandonandoti magari solo per una sera o addirittura per una manciata di minuti … che però cambieranno per sempre il corso della tua vita.
Questo è quello che accadde a Marco Pacione. È il 19 marzo del 1986. La Juventus affronta al Comunale di Torino il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale della Coppa dei Campioni. I bianconeri sono campioni uscenti. Hanno vinto nella tragica finale dell’Heysel del maggio precedente. Però muoiono dalla voglia di vincere una Coppa dei Campioni vera.
È una Juventus rinnovata che ha salutato giocatori del valore di Zibì Boniek e Paolo Rossi e ha accolto giovani di sicuro avvenire come Aldo Serena e Lionello Manfredonia. C’è ancora ovviamente Michel Platini, c’è Antonio Cabrini e c’è Gaetano Scirea. All’andata, contro un tutt’altro che trascendentale Barcellona, la Juve ha perso per una rete a zero. Una ciabattata nel finale del terzino Julio Alberto (un altro “maledetto” di cui varrebbe la pena di raccontare) ha deciso un match che la Juventus aveva perfettamente sotto controllo ma alla quale è mancato il coraggio per andare al Nou Camp e imporre la propria superiorità come probabilmente avrebbe dovuto. In panchina, neanche a dirlo, c’è Giovanni Trapattoni che del pragmatismo del “primo non prenderle” ha fatto la sua filosofia calcistica.






Il Barcellona non è certo lo squadrone che è stato per buona parte della propria gloriosa storia. Ha perso Maradona due anni prima (destinazione Napoli) e in panchina c’è Terry Venables, buon allenatore per una panchina inglese ma decisamente a disagio su una così pesante e ingombrante come quella dei Blaugrana. In campo ci sono giocatori come Moratalla, Esteban, Calderè … gente buona per il Betis Siviglia o il Real Saragozza (con tutto il rispetto). Il pericolo principale è il centravanti scozzese Steve Archibald per cui vale lo stesso discorso di Venables. Buono per il calcio britannico ma inadatto a guidare l’attacco dei catalani.
Anche la Juventus però qualche problema ce l’ha. Briaschi dovrebbe essere il centravanti ma all’andata è dovuto uscire dopo dieciminuti e Aldo Serena, l’altro attaccante titolare, e anch’egli ai box. A questo punto la scelta cade per forza su Marco Pacione.

È, per caratteristiche, l’alternativa a Serena. È’ alto quasi 190 centimetri ma è sorprendentemente mobile per un calciatore della sua stazza. È arrivato dall’Atalanta nell’estate precedente dopo una lusinghiera stagione d’esordio nella massima serie l’anno precedente e soprattutto dopo la conquista del titolo di capocannoniere del campionato cadetto due stagioni prima. Solo che è evidente che alla Juve, Trapattoni per primo, non hanno una grande fiducia in lui. Nei sette mesi precedenti ha giocato solo due partite dall’inizio. E ora si trova in campo da titolare nel match più importante della stagione.



A Torino fa freddo quella sera ma il calore dei tifosi juventini spinge i proprio beniamini all’assalto. Per mezz’ora è una bella Juventus. Che si lancia in un arrembaggio autentico. Platini disegna traiettorie come solo lui sa fare imbeccando i compagni anche a 30 o 40 metri di distanza. Il giovanissimo danese Michael Laudrup crea scompiglio con le sue percussioni e le sue eleganti veroniche. Bonini e Manfredonia sono una diga a centrocampo. Rubano palla e poi la consegnano nei piedi dei loro due più talentuosi colleghi.
Dopo pochi minuti c’è la prima grande occasione da gol. Laudrup, dopo uno slalom degno di Alberto Tomba, appoggia un pallone d’oro al centro dell’area, forse un paio di metri fuori dall’area piccola non di più. Marco Pacione deve solo spingere la palla in rete.

Ci va di esterno invece che di piatto e probabilmente la palla non rimbalza neppure benissimo sul prato del Comunale indurito dal freddo piemontese. Fatto sta che Pacione manca quasi completamente l’impatto con la palla che rotola lemme lemme a fondo campo a 4-5 metri buoni dal palo di Urruticoechea, il grande portiere basco del Barcellona. Marco Pacione rimane impietrito, mani sui fianchi, mentre guarda scivolare il pallone sul fondo. Ci sono compagni che si disperano, qualcuno rimane incredulo. Perfino alcuni fotografi dietro la porta imprecano e gesticolano di rabbia.
C’è ancora tempo.
La partita è appena iniziata e la mole di gioco sviluppata dai bianconeri lascia intendere che di occasioni ce ne saranno tante altre. Sarà così. Solo che capiteranno praticamente tutte sui piedi (o sulla testa) di questo ragazzone generoso, forte come un toro e altruista come pochi. Le fallirà tutte.
Dal nulla, poco dopo la mezz’ora, arriverà il gol di Steve Archibald, con un colpo di testa tutt’altro che irresistibile. Una palla toccata un gol. Un cecchino. L’esatto contrario di Marco. Rivedendo quelle occasioni in realtà solo la prima, quella raccontata qui sopra, è davvero clamorosa.

Le altre, in partite diverse da un quarto di finale di Coppa dei Campioni e magari solo diluite in due o tre partite, sarebbero tranquillamente archiviate come “opportunità fallite”. Non quella sera e non dopo che ti capitano tutte in poco più di 20 minuti di gioco. La Juventus segnerà il gol del pareggio prima della fine del primo tempo ma sarà incapace di perforare la difesa del Barça nel secondo tempo.
Ecco fatto ! Fuori dalla Coppa dei Campioni. A fine partita però nessuno parla della tattica timorosa e pavida dell’andata, o della clamorosa “papera” di Tacconi sul gol di Archibald o della foga con poca lucidità degli attacchi juventini nella ripresa. La testa sul ceppo, l’unica, è quella di Marco Pacione. Ed è un’ingiustizia enorme … ma che fa comodo a tutti.
Questo ragazzone abruzzese, magari non un fenomeno ma un attaccante con tante e importanti qualità, sarà ricordato in eterno da tutti (o quasi) solo per quella notte maledetta… capitata in una squadra che del motto “vincere non è importante … è l’unica cosa che conta” ha fatto la sua filosofia assoluta e che i “perdenti” proprio non li tollera, non li considera … anzi, se può li cancella dalla propria memoria.



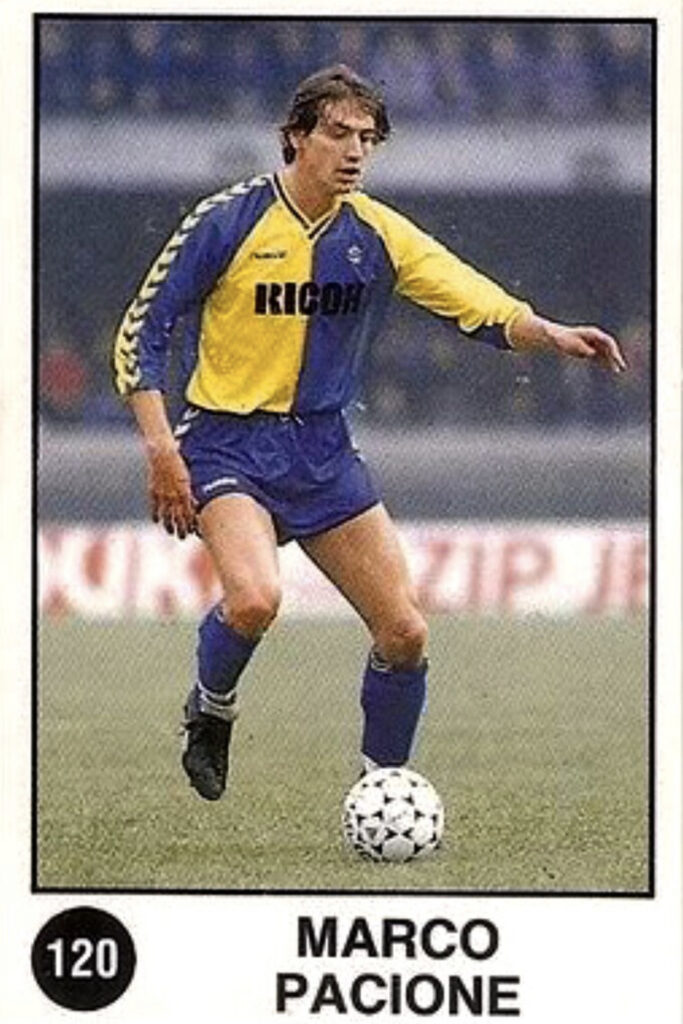

Come Marco Pacione.
Marco Pacione nasce a Chieti nel luglio del 1963. Come per tantissimi ragazzi nella storia del calcio italiano i primi ad accorgersi di lui sono gli scout dell’Atalanta. Alla “Dea” capiscono di calcio come pochi e non si lasciano sfuggire questo ragazzo. Non ha ancora 20 anni quando fa il suo esordio con i nerazzurri in Serie B. Ben presto si ricava un posto nell’undici titolare ma è nel campionato successivo che Marco Pacione diventa uno degli attaccanti più ambiti dai grandi club. La “Dea” torna in serie A con una cavalcata trionfale e Marco è il protagonista assoluto. I suoi 15 gol gli valgono il titolo di miglior marcatore del campionato.
La Juventus, che nel recente passato dall’Atalanta ha pescato a piene mani, (Scirea, Cabrini, Marocchino, Prandelli, Fanna) batte l’agguerrita concorrenza di Inter e di altri grandi club. L’idea è di far crescere il ragazzo piano piano, nel puro “stile Juve”, dove prima ti formano il carattere e poi quando sei pronto vai anche in campo. Solo che in quella sera maledetta di marzo Marco Pacione si gioca tutto. L’autostima finisce sotto i tacchi e nelle 12 partite in cui scende in campo in quella stagione non c’è verso di mandare quella dannata sfera di cuoio in fondo alla rete. Viene ceduto (sbolognato forse è il termine più appropriato) al Verona la stagione successiva.
E qui, a Verona, ritorna il ragazzo di Bergamo. Quello che si carica sulle spalle il peso dell’attacco, quello che fa a sportellate con i difensori avversari e apre spazi per i compagni, quello che “sgonfia” un’infinità di palloni che sembrano impossibili e li fa diventare giocabili … quello che qualche gol lo fa ancora e che dà una mano importantissima ai compagni a raggiungere un fantastico quarto posto finale che vale un posto nella vecchia Coppa UEFA.
A Verona rimarrà tra stagioni e nella città scaligera si ricorderanno per anni di lui per tutto quello che sapeva dare al team domenica dopo domenica … non per quello che non ha saputo dare in venti minuti maledetti.
Poi arriva il 12 febbraio del 1989. E quel giorno “il vento completerà il suo giro”. Si gioca Verona – Juventus. Non è una Juventus trascendentale quella di quella stagione. Buso, Zavarov, Barros, De Agostini … buoni giocatori ma niente di più. Anche il Verona non è più quello di qualche stagione prima ma è ancora una dignitosissima squadra. In quella stagione poi sono arrivati due argentini: uno di “garra” pura come Pedro Troglio e l’altro è un “fulmine biondo” che si chiama Claudio Caniggia. Sulla panchina c’è ancora Osvaldo Bagnoli, uno degli allenatori più bravi e sottovalutati della storia del calcio italiano.
Bagnoli che in quella stagione affida la fascia di capitano proprio a lui, a Marco Pacione, esemplare professionista e leader di un team che sa rendere difficile la vita a tutti gli squadroni del campionato italiano. Finirà così. Altro che le stucchevoli braccia alzate in segno di scusa ormai diventate di moda tra chi segna alla propria ex-squadra. Marco Pacione esulta soddisfatto dopo il primo gol ma è dopo il secondo che esplode la sua gioia.
Intanto per la bellezza del gol: un’incornata potentissima e precisa sul calcio d’angolo di Bortolazzi. E poi c’è la rabbia da buttar fuori. Quella tenuta dentro per quasi tre anni. Quella contro chi ti ha prima lusingato, ti ha trascurato per mesi, poi ti ha buttato nella mischia utilizzandoti come “bersaglio” per giustificare un fallimento e infine messo da parte come un paio di scarpe vecchie. Marco Pacione si farà settanta metri di corsa esultando con tutto il popolo veronese.
Da quel giorno in poi, alla Juventus, avranno un altro buon motivo per ricordarsi di lui. Perché Marco Pacione è stato molto di più di quei maledetti venti minuti.
